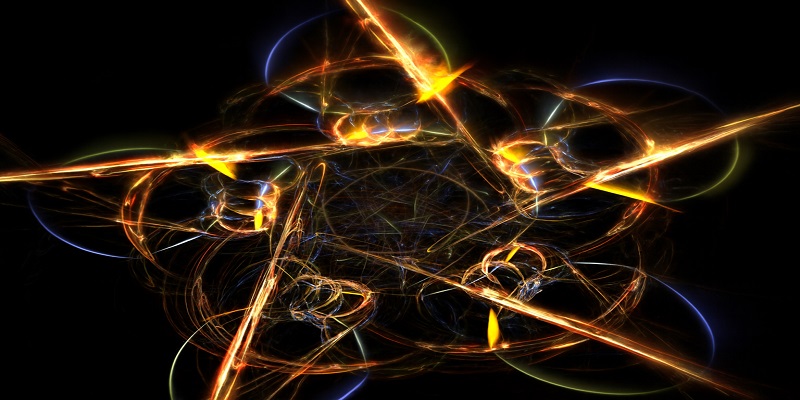Là dove osano i movimenti
Sulla ‘singolarità’ della sollevazione per la Palestina, un patrimonio comune da preservare. Un documento dei Centri Sociali Marche
In queste settimane abbiamo visto diversi tentativi di lettura e comprensione di quella mobilitazione straordinaria e dirompente, che si è prodotta attorno alla Palestina, al fianco della sua Resistenza, contro il genocidio e a sostegno di quel processo di solidarietà internazionale che ha rappresentato la Global Sumud Flotilla.
Crediamo, in questo tempo e a questo livello, che sia un esercizio utile provare ad individuare alcune linee di tendenza e alcune tracce fondamentali che hanno lasciato e stanno lasciando i diversi tentativi d’interpretazione.
Molto spesso, anche per riuscire a costruire e costruirci un ordine del discorso sensato abbiamo la necessità di provare a nominare quello che accade, soprattutto a livello sociale e politico. Questa necessità, però, deve essere in grado non solo di dare un nome, ma anche di cogliere il segno, i solchi. Nominare prima di tutto è riconoscere. In questi giorni abbiamo sentito in più occasioni chiedersi “Ma quello per la Palestina è davvero un movimento?”, come se la dimensione di movimento dell’opposizione sociale dipendesse dalla definizione soggettiva di qualcuno. In realtà sono solo i processi di cambiamento, l’impatto reale di una vicenda collettiva sulle condizioni materiali di esistenza, che sono in grado di assumere, e quindi, di riconoscere la nascita e lo sviluppo di un movimento.
Ed è fuori dubbio che la dinamica di mobilitazione collettiva che si è prodotta in difesa del popolo palestinese è stata in grado di incidere addirittura su dimensioni globali, di bloccare realmente snodi fondamentali della vita economica e sociale del Paese e di riportare al centro dell’azione e dell’immaginazione la forza dell’autorganizzazione sociale: quella forza autorganizzante che nell’inerzia e nella complicità di tutta la matassa istituzionale (nazionale, europea e internazionale) ha scelto di agire in autonomia, di costruire un discorso pubblico egemone nelle e con le forme di lotta che si è dato, di imporre temi, tempi e obiettivi con una spinta straordinaria, imprevedibile secondo i canoni classici di lettura politica. Tutto ciò fa di una vicenda collettiva un movimento, un movimento che necessariamente è figlio della storia a cui appartiene, interfaccia conflittuale dello stesso disciplinamento che decide di rompere e oltrepassare.
Pensare che in una contemporaneità segnata da cambiamenti antropologici, dove la comunicazione non è semplicemente strumento dell’organizzazione, ma essa stessa processo organizzativo in atto, i movimenti possano darsi secondo le fisiologie “tradizionali” significa in realtà pensare e vivere in un altro tempo. Se vogliamo davvero analizzare per rilanciare, capire per diffondere, dobbiamo entrare nelle dinamiche attuali, dotarci nell’epoca dell’intelligenza artificiale piuttosto che di un approccio geometrico-lineare, di un approccio “quantistico” capace di cogliere la correlazione dinamica che unisce le singole particelle di un fenomeno in un sistema di plurime interazioni che in ultimo compongono l’azione collettiva.
Il movimento si è sviluppato e diffuso seguendo dinamiche, dispositivi e connessioni che hanno costantemente rielaborato gli input iniziali riposizionandoli ogni volta su un terreno più avanzato. Questa volta non c’è stato nessun “centro” che avesse la pretesa di rappresentare e direzionare il tutto, nessun luogo che ambisse ad essere lo spazio generale di “organizzazione” delle possibilità: ciononostante l’agire comune non si è disperso in un caotico spontaneismo, ma ha trovato le proprie forme di auto-organizzazione ed ha perseguito efficacemente i propri obiettivi. Anche sul terreno dei contenuti sotto l’ombrello della questione palestinese i nodi conflittuali si sono diversificati mettendo a nudo la fine dell’illusione liberaldemocratica del diritto internazionale, l’intreccio inscindibile tra capitalismo, guerra, ingiustizia e genocidio, la crisi profonda dell’intero impianto istituzionale interno ed esterno, la legittimità della resistenza armata da parte di un popolo oppresso. Sul versante delle pratiche di lotta, nel volgere di poche settimane le mobilitazioni hanno ricostruito il senso ed il significato più profondo dell’autonomia dei movimenti, restituendo al concreto terreno dell’azione l’esercizio dell’illegalità di massa e aprendo spazi di conflitto che nel cupo periodo dell’opposizione al ddl sicurezza apparivano irraggiungibili.
Così, quasi a voler rendere di quell’autonomia una visione plastica e simbolica, nella nostra regione mentre si riempivano le piazze e si bloccava il porto con le principali vie di comunicazione, il “campo largo” naufragava miseramente nell’ennesima tornata delle elezioni regionali, nonostante l’endorsement (del tutto fuori luogo) dei parlamentari che avevano partecipato alla Flotilla.
Condizioni, caratteristiche e dinamiche all’interno delle quali si è prodotto il movimento sulla questione palestinese non possono essere analizzate separatamente perchè altrimenti si rischierebbe di non cogliere la dimensione complessiva del fenomeno e, con essa, la profonda discontinuità che le mobilitazioni di queste settimane hanno segnato rispetto a precedenti vicende di “espressione” collettiva. Perdere di vista il dato della discontinuità significa perdere di vista gli elementi di novità con cui invece dobbiamo misurarci, che oggi ci costringono ad interrogarci sulle nostre prassi, sulle forme e le modalità con cui è possibile costruire passaggi successivi senza perdere il legame con la dimensione reale del conflitto che si è dato. Il che significa capire come essere propositivi e propulsivi restando però dentro la fisiologia e le caratteristiche del movimento che si è prodotto. E questo non per creare modelli o idealizzare vicende, ma semplicemente perchè questo è il terreno materiale su cui oggi siamo chiamati a muoverci perchè in esso si è espressa una potenza sociale straordinaria.
Eppure a pochi giorni da quelle mobilitazioni emergono già le tentazioni nefaste di provare ad andare all’incasso, di estrarre da quell’enorme patrimonio pezzi di ricchezza comune da mettere al servizio dei propri obiettivi di parte. Appare davvero irreale che nel volgere di un così breve lasso di tempo emerga già il tentativo di confinare quella potenza sociale nei recinti di strutture politiche e forme partitiche, impegnati da qui ad un tempo indefinito, in opzioni elettorali future. Opzioni istituzionali e istituzionalizzanti che peraltro si collocano in un tempo in cui il campo istituzionale è oramai travalicato persino dai suoi reali padroni. Il vecchio vizio politicista che soffoca invece di liberare. Il vecchio tic del ceto politico che depotenzia e confina, invece di lasciar respirare e sedimentare.
Ma il problema non è limitato al tentativo di insediare nel corpo del movimento fantomatiche rappresentanze che possano giocarsi la partita delle prossime elezioni politiche, riproponendo la visione sempre più caricaturale e irrealistica della spasmodica ricerca di un nuovo condomino del palazzo di governo.
Perchè il movimento possa fare passi in avanti è necessario che in questa fase di grande accumulo facciano un passo indietro anche le visioni precostituite, le prassi che si ripetono nel tempo sempre uguali a se stesse, l’idea che le dinamiche di movimentazione sociale debbano trovare da subito una sintesi. E’ necessario rompere lo schema classico che vede nella costruzione di un “luogo” centrale la possibilità di assumere la funzione ordinatrice di ciò che è stato e delle sue prospettive future. La costruzione in questa fase di sovrastrutture fatte di sigle che nel contempo si contendono la visibilità e si accreditano reciprocamente il ruolo di direzionamento, produce dinamiche regressive, molto probabilmente destinate a sfociare in una qualche rappresentazione di piazza, magari con numeri grottescamente gonfiati, che sistematicamente segna la fine di una storia. Anche laddove simili operazioni fossero produttive nell’immediato di un qualche risultato, ciò non servirebbe comunque ad evitare l’effetto di chiusura e restringimento che esse portano con sé, l’inefficacia di spazi di discussione che in realtà di discussione e di confronto hanno ben poco, riducendosi ad una carrellata di microcomizi, volti a ratificare decisioni già prese.
Le mobilitazioni per la Palestina sono state il risultato di un processo totalmente diverso, dove la discussione si è sviluppata all’interno delle molteplici maglie di un reticolato in movimento, individuando obiettivi e pratiche modulari all’interno dei territori. Idee e proposte si sono sviluppate attraverso una comunicazione circolare che ha destituito lo schema comunicativo del “centro verso la periferia”, conquistando così autonomia, agilità e tempestività. Ogni percorso che si è dato in quelle settimane pur in assenza di luoghi generali di rappresentanza e coordinamento, ha concorso sinergicamente alla produzione del comune discorso pubblico e all’accumulo di eccedenze capaci di spostare ancora più avanti gli obiettivi e le pratiche.
I risultati ottenuti sono stati il frutto di una molteplicità di fattori e condizioni, comprese quelle di natura percettiva, che l’intelligenza collettiva è stata capace di “processare” nel corso stesso dell’agire, del farsi movimento generalizzato e generalizzante. La molteplicità dei fattori, dei piani e delle circostanze intervenuti in questa processualità sociale fa sì che la straordinaria finestra di conflittualità sociale che si è aperta costituisca una sorta di “singolarità”, inscindibile dalle condizioni che l’hanno prodotta. Immaginare che quella singolarità possa essere traslata, trasferita meccanicamente in altri contesti come in un grande gioco dei pacchi, è, a nostro avviso, una grave semplificazione di ciò che abbiamo appena vissuto. Il problema non è come riprodurre una singolarità, cosa evidentemente contraddittoria in sé, ma come riprodurre i processi che sono in grado di generare una nuova e diversa singolarità su altri terreni. Ciò nella consapevolezza che la parabola di una singolarità tende ad avere dinamiche e tempi diversi rispetto al classico concetto di “ciclo di movimento” e che probabilmente sarebbe più appropriato ragionare in termini di “fluttuazione” della conflittualità sociale.
L’interrogativo primario con cui dobbiamo misurarci oggi è, dunque, come sviluppare proposte e immaginare passaggi che restino però dentro la fisiologia dei processi che si sono dati in queste straordinarie settimane di lotta, come salvaguardare l’autonomia così prepotentemente affermata e rivendicata dal movimento, come evitare di confondere il ruolo propulsivo della soggettività con una sua deriva ordinatrice che oggi significherebbe togliere ossigeno laddove c’è bisogno di aria, sovrascrivere percorsi con obiettivi esterni rispetto ai reali processi sociali, scegliere la certezza della riduzione rispetto al rischio degli ampi orizzonti che ci spaesano. Certo il problema è complesso e le soluzioni non sono facili, ma la difficoltà delle soluzioni non rende più appetibile il ripiego su meccanismi che sappiamo già perdenti.
Non crediamo che questo sia il momento di grandi assisi nazionali che magari immaginano di immettere come prospettiva di continuità delle mobilitazioni obiettivi che nascono in tutt’altri contesti, come quelli d’oltre oceano, e che a loro volta in quei contesti rappresentano una singolarità figlia delle specifiche condizioni che l’hanno prodotta. Ad oggi, se vogliamo individuare delle prospettive nel breve periodo, ci appare più credibile e coerente con quello che abbiamo appena scritto, riflettere e concentrarsi sullo sciopero generale del 28 novembre, provare a capire, immaginando proposte e pratiche, come anche quella data possa entrare a fare parte del processo di accumulo delle nuove forme di conflittualità sociale, come il rifiuto della guerra, della sua economia e della sua propaganda possa andare a costituire un nuovo ed ulteriore volano di un agire comune e collettivo.
Siamo sempre stati e ancora siamo materialisti. Questa frase, così semplice e diretta, molto spesso fraintesa o vilipesa, in realtà, ci permette di continuare a ragionare della e sulla realtà, dentro le sue contraddizioni e le sue ambivalenze.
Essere materialisti, prima di tutto, significa negare, profondamente e convintamente, ogni semplificazione deterministica e ogni riduzionismo. La realtà sociale, le sue manifestazioni di lotta e di conflitto, come quelle opposte di obbedienza e di paura, non sono riducibili ad un volgare meccanicismo o ad uno sterile ideologismo.
E’ solo nelle condizioni materiali che possiamo misurare l’efficacia delle nostre azioni e la giustezza degli obiettivi. E sono sempre le condizioni materiali che ci consegnano gli “indizi” di una pratica possibile, di un processo in atto, di una trasformazione che inizia ad attraversarci prima ancora che ne sentiamo gli effetti. La realtà materiale che ci restituisce la sollevazione contro il genocidio del popolo palestinese è un patrimonio comune, un valore che genera valore, ma che ci impone anche il coraggio dell’azzardo, lo sforzo di comprendere la discontinuità per ricostruire la continuità delle lotte. Di quelle lotte che non sono un hobby o un previlegio, ma la cruda necessità di un’esistenza che non può non desiderare di essere libera.
Centri Sociali Marche
– Il documento in formato pdf scaricabile